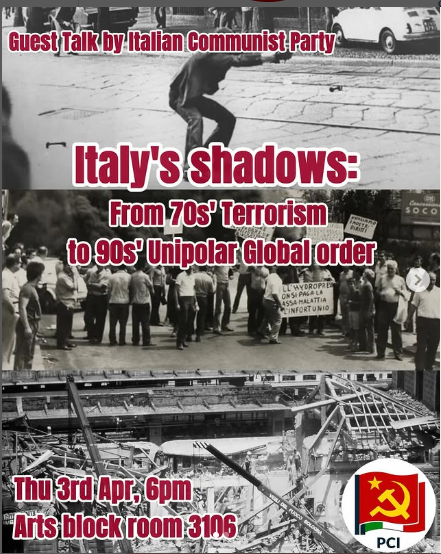Trascrizione della relazione di Luca Rodilosso (dipartimento internazionale PCI) al convegno organizzato dal collettivo studentesco del Workers’ Party Irlandese presti il Trinity College di Dublino. Si ringrazia il canale YouTube “Rosso Fastidio” per la pubblicazione.
———————
L’Italia non è mai stata fino in fondo una democrazia costituzionale compiuta. Per lo meno se si intende come “costituzione” quella antifascista uscita dall’Assemblea costituente del 1948.
Fin dai primi anni cinquanta tentativi di ristabilire all’interno delle strutture di polizia e delle gerarchie dello stato le vecchie nomenclature del regime fascista hanno sempre trovato terreno fertile, con la complicità della destra della Democrazia Cristiana e con la collaborazione di settori deviati dello stato compresi diversi comandi di alcuni servizi segreti.
Uno dei primi meccanismi che anticipano la gestione degli anni di piombo, ne è di fatto prodromo, è quello dell’influenza mafiosa nelle strutture dello stato. È in quella dinamica che si sviluppa il giornalismo di inchiesta, basato su giornali di area democratica e progressista che non volevano sottostare al senso comune istituzionale pubblico e all’omertà anche delle procure.
In quel mentre segmenti di borghesia e di classe imprenditoriale non disposta all’aumento dei salari e a una revisione delle politiche del costo del lavoro tornano, non contente dell’assetto istituzionale democratico creatosi nel dopoguerra, a rivolgersi a forze nascoste nel paese, ivi compresa la manovalanza mafiosa.
Dopo gli anni cinquanta, gli anni sessanta sono contraddistinti da una sempre più serrata lotta sociale: vedono il fallimento del governo Tambroni, tentativo della ala destra della Democrazia Cristiana di governare col movimento sociale Italiano (il movimento erede del partito fascista).
Ma vedono anche l’unificazione delle lotte di studenti e operai concretizzatasi nel 1968. Si costituiscono collettivi a tutti i livelli di carattere non solo studentesco ma anche professionale: molto interessante risulta la costruzione del “collettivo politico giuridico” che riunisce attorno a sé numerosi giuristi, docenti universitari, avvocati, tutti dediti alla difesa nei processi e al lavoro di contro informazione per sostenere le battaglie politiche delle sinistre.
Nel 1969 il 12 dicembre a Milano esplose una bomba alla banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana. Questo fu l’inizio, il primo atto, di quello che venne poi definita dalle inchieste di controinformazione la Strategia della tensione.
Il primo atto delle inchieste di controinformazione fu quello dell’uscita di un libro a cura proprio del collettivo politico giuridico: “La strage di stato”, che uscì il 13 giugno 1970.
Raramente un titolo ha assunto con tanta efficacia il contenuto di un libro e probabilmente questo fu il primo motivo del suo successo.
L’inchiesta partiva dalla strana morte di Armando Calzolari, avvenuta il 28 gennaio 1970 appunto egli fu un dirigente del fronte Nazionale, movinento di estrema destra fondato da Junio Valerio Borghese. Un ex-maro della X-Mas robusto in perfetta salute cadde in una buca di 80 cm piena d’acqua e ci annegò col suo cane. In una prima fase la procura Romana chiese di archiviazione dell’inchiesta per morte accidentale. Dopo diverse testimonianze, in caso venne chiuso come omicidio ad opera di ignoti. Stando alle testimonianze Calzolari avrebbe partecipato riunioni di Fn con alti ufficiali, finanzieri, politici e persino prelati. Questo membro (Calzolari) avrebbe dedotto che ci fossero responsabilità nella strage milanese di Piazza fontana e avrebbe quindi deciso di parlare.
La strage di piazza fontana sarebbe stata parte di un piano finalizzato a respingere le lotte sociali in atto e a buttare i socialisti fuori dal governo, ripristinando una coalizione centrista aperta al movimento sociale Italiano. A ciò sarebbe dovuto seguire un colpo di stato di tipo greco.
L’autore di questo piano sarebbe stato il “partito americano” composto dai socialdemocratici, dalla destra della Democrazia Cristiana, dai repubblicani, dai liberali, dai missini e dalla Confindustria e da tutti gli apparati repressivi militari del paese.
Vi fu quindi un depistaggio che venne volutamente collegato ad una pista anarchica, questo perché l’ambiente anarchico era abbondantemente infiltrato e quindi controllabile nonché elemento per poter essere utilizzato al fine di inquinare le acque.
Diverse ipotesi successive arricchirono gli elementi e di organizzazioni neofasciste le inchieste giudiziarie ma il merito di questo libro fu quello di aver dato una versione differente da quella che i principali organi di informazione fecero trapelare all’epoca e che fu poi alla base di una diversa interpretazione dei fatti e delle stragi.
Il caso Borghese
Nel pomeriggio del 17 marzo 1971 il ministro dell’Interno Franco Restivo rese pubblico in Parlamento il tentativo di colpo di stato operato dal fronte nazionale di junior Valerio Borghese, nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 1970 (notte della Madonna).
Molti anni dopo si saprà che sarebbero stati oltre 20.000 i militanti della Destra eversiva pronti a entrare in azione, che erano stati avviati i contatti con la mafia i cui uomini avrebbero dovuto rapire e uccidere il capo della polizia Vicari, e che un altro gruppo guidato da Licio Gelli avrebbe dovuto arrestare il Presidente della Repubblica Saragat.
A seguito di queste notizie, e dell’arresto dei principali eversori che però quasi tutti ripararono all’estero, i sindacati indissero uno sciopero generale e si svolsero cortei con centinaia di migliaia di persone in tutta Italia con le federazioni del PCI, camere del lavoro e i giornali di sinistra mobilitati.
Di fatto a questo episodio storico seguirono numerosi altri eventi a carattere stragistico. Nel 1973 vi fu il colpo di stato in Cile, che portò il PCI a ricercare interlocuzioni nella Democrazia Cristiana al fine di “salvare” l’assetto democratico del paese e ad attivare la strategia del “compromesso storico”.
Il principale interlocutore di questa strategia dentro la Democrazia Cristiana, Aldo Moro, pagherà caramente questa disponibilità agli occhi di quelle forze reazionarie che hanno tenuto e ancora oggi tengono, sotto nuove forme e dinamiche, in ostaggio il nostro paese.
Il 28 maggio 1974 durante un comizio, una manifestazione sindacale a Brescia, in Piazza della Loggia, venne colpita da una bomba e anche in quell’occasione vi furono 9 morti e decine di feriti. Peraltro la manifestazione era stata indetta proprio per condannare diverse attività eversive emerse, per alcuni fatti di cronaca collegati proprio al territorio bresciano, che vedevano coinvolti militanti e esponenti neofascisti.
Durante la notte tra il 3 e 4 agosto 1974 un’altra bomba provocò la morte di 12 persone sul treno Italicus, treno che l’on. Aldo Moro avrebbe dovuto prendere in quel frangente per andare a trascorrere un periodo di ferie ma che non prese a causa di alcuni documenti e impedimenti burocratici che lo trattennero a Roma.
Ma questa strategia stragistica non stava ottenendo, per una serie di reazioni democratiche insite nel paese e nelle forze sociali progressive, risultati utili e necessari al sentimento di terrore nell’opinione pubblica che tale progetto si prefiggeva di instillare.
Il PCI e le sinistre in generale, intimorite a loro volta a questo pericolo per la democrazia, ridussero progressivamente una serie di rivendicazioni salariali e sociali al fine di ottenere un compromesso con la Democrazia Cristiana per poter salvaguardare l’assetto democratico, e questo portò all’emergere di una nuova variabile di difficile controllo e gestione: lo scontento e la frustrazione dei lavoratori dal lato “sinistro” del quadro politico, e la nascita di formazioni di estrema sinistra che ripresero una visione culturale legata anche all’evenienza della lotta armata, dismessa dal PCI dai tempi della svolta di Salerno di togliattiana memoria.
E’ all’interno di questo quadro che va letta la nascita di un’organizzazione che inevitabilmente segnerà la svolta di un’epoca, ovvero le Brigate Rosse – BR.
Questa organizzazione, nata in alcuni circuiti di fabbrica milanesi da esponenti anche del ceto medio a contatto col mondo operaio, criticava alla radice la natura del PCI e le scelte politiche intraprese dal Partito Comunista sin dai tempi della formazione del testo costituzionale della Repubblica Italiana, e rispondeva a quella sensazione di impotenza che molti settori operai vivettero con l’attuazione della strategia del “compromesso storico” verso la DC da parte della dirigenza del PCI.
Come tutti i fatti umani, anche le BR nacquero per genesi endogena, ma ai fini della destabilizzazione e della gestione del consenso da parte di forze molto più rilevanti, i fattori esogeni di influenza e infiltrazione non tardarono ad arrivare, in gran numero e con grande interesse: dai servizi segreti italiani, servizi israeliani fino probabilmente alla CIA medesima.
Il rapimento e la successiva uccisione di Aldo Moro nel 1978 rappresentarono il compimento di un percorso che, nella sostanza, vide una sistematica regia atta a non permettere che una forza di reale cambiamento come il Partito Comunista Italiano potesse prendere le redini del governo in un paese dell’Europa occidentale e inserito nella NATO. Ma con una differenza importante e fondamentale nei fatti: non più generali, colonnelli, gruppi di eversori neofascisti commisero l’atto di rottura, di uccisione di un politico “scomodo”, per quanto moderato. A compiere tale atto fu un’organizzazione apparentemente rivoluzionaria, per giunta autodefinitasi “Comunista”. Una nuova prospettiva si apriva quindi ai fautori delle destabilizzazioni internazionali: per cambiare le sorti politiche di un paese, non è detto che fosse più necessario ricorrere solamente alla manovalanza neofascista o ai settori reazionari e/o conservatori della società e dell’esercito, ma si potevano invertire i fattori persino della narrazione stessa, sovvenzionando – o implicitamente favorendo anche con il “lasciar fare” – gruppi terroristici apparentemente rivoluzionari e progressisti.
Nel mentre di tutti questi avvenimenti, si doveva profilare un nuovo sistema di valori e di gestione della politica e della società: a questa nuova visione teorica provvedette una loggia massonica, la “Propaganda 2”, che impostò l’assetto teorico di una nuova “democrazia” a carattere fortemente presidenzialistico, ancorata saldamente al sistema capitalistico e dove due forze di sistema, una blandamente di sinistra e l’altra saldamente conservatrice, avrebbero previsto e gestito una dinamica di alternanza che non mettesse in discussione l’impostazione economica di uno Stato che in sostanza avrebbe dovuto rinunciare a una sua piena sovranità popolare.
Dopo il delitto Moro, e fallito il compormesso storico con la caduta del governo Andreotti IV nel 1979, l’unico impianto reale rimasto in piedi fu proprio quello previsto dalla Loggia P2: una “democrazia” controllata e, di fatto, conservativa.
E da questi anni spartiacque in avanti, in Europa, non vi furono più colpi di stato militari o regimi fascisti (Spagna, Grecia e Portogallo si erano da poco liberati dei loro regimi), ma venne introdotta una nuova retorica, quella della “vittoria della democrazia”, ma questa volta non più sul fascismo (strumento sempre utilizzabile all’occorrenza), ma sui partiti comunisti dell’Europa Occidentale, a partire da quello più forte all’epoca, ovvero il PCI.
Fu la stessa retorica che poi arrivò, ineluttabilmente, a travolgere tutti i regimi comunisti dell’Est Europa nel 1989-1991, con le “rivoluzioni democratiche” contro la tirannia (comunista): il sindacato “Solidarnosc’” sfruttò le radici cattoliche del sentimento popolare polacco ma seguì quel tipo di caratterizzazione “rivoluzionaria” contro un regime geopoliticamente scomodo. Anche il movimento studentesco di Piazza Tien’Anmen in Cina sviluppava una natura similare di “ribellione contro il potere” con spettatori esternamente interessati.
Negli anni ‘90, quello che per semplificazione e comodità chiameremo “modello BR”, ovvero quello di un gruppo estremista che si opponeva a un regime geopoliticamente scomodo “da sinistra”, venne utilizzato in Serbia con il movimento studentesco “Otpor”, il cui simbolo era guardacaso un pugno chiuso alzato; tale impostazione seminerà altri sviluppi che sfoceranno invece nei primi anni duemila nella “rivoluzione arancione” in Ucraina e nella “rivoluzione delle rose” in Georgia, nella “rivoluzione del bisonte” in Bielorussia, fino ad arrivare alle “primavere arabe” nel periodo successivo al 2010.
Ovviamente ogni situazione nazionale ha mantenuto proprie caratteristiche e peculiarità, e sicuramente ogni movimento destabilizzatore nasce sempre da fattori interni di scontento popolare legati anche all’inadeguatezza dei governi e dei regimi oggetto di attacco politico. Ma non si può negare che l’Italia, con la sua esperienza storica, segnò un profondo cambiamento nella strategia internazionale prevalentemente statunitense, che dal 1978 in avanti iniziò a prendere in considerazione come la “democrazia” da loro intesa potesse vincere sulle forze comuniste e anti-imperialiste, e sui nemici geopolitici come Russia e Cina, utilizzando retoriche e strumenti di ribellione apparentemente rivoluzionari, oltre che i soliti sistemi autoritari di repressione.
Se oggi siamo ancora in una situazione di tensione internazionale significa che questa impostazione strategica e retorica della “democrazia occidentale” come unico modello valido e vincente, non ha funzionato fino in fondo. E infatti gli sconvolgimenti del nuovo trumpismo di questi mesi stanno a dimostrare come gli USA siano alla ricerca affannosa di una rimodulazione strategica, sia per i primati economici che per quelli geostrategici internazionali.
Grazie per l’ascolto.